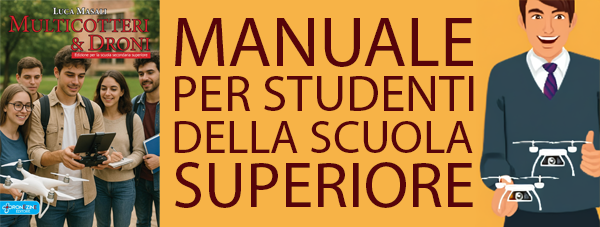A due mesi dal lancio del patentino online, continuano ad arrivare in redazione segnalazioni di errori tecnici e ortografici, domande fuori contesto o ambigue. Se all’inizio potevano essere dei problemi di gioventù, frutto di un servizio ancora in beta, ora andrebbero rivisti.
ENAC ha fatto un grande sforzo ammirevole nel mettere a punto in breve tempo l’esame online, un prezioso strumento per garantire che tutti coloro che volano abbiano le basi culturali necessarie. In generale si tratta di domande ben fatte e ben calibrate. Ormai sono mesi che abbiamo il patentino online, ed ENAC ancora non interviene sui problemi di gioventù della sua piattaforma. In molti casi è solo mancanza di controllo editoriale che si trasforma in errori di ortografia sicuramente fastidiosi per un Ente pubblico, ma ormai la correzione di bozze è considerata un lusso superfluo anche dai quotidiani (e ammettiamolo anche noi facciamo i nostri). Ma insomma, un poco di cura non guasterebbe, avere errori di ortografia sui quiz di un esame pubblico è un po’ come se un ispettore ENAC si presentasse a fare una ispezione con macchie di caffè sulla giacca: non bello a vedersi, non molto cortese nei confronti del pubblico, ma niente di più.
Ben diverso è quando ci troviamo davanti a domande ben strane, e sebbene siano una minoranza gli esempi non mancano. Ecco alcuni quiz segnalati da lettori, e su queste facciamo una bella recensione satirica:
Che ci fa Murphy nell’esame di un Ente pubblico?
La legge di Murphy afferma che:
° Le aspettative influenzano le percezioni
° Le prestazioni sono influenzate dalle motivazioni
° Se un malfunzionamento può avvenire, questo prima o poi avverrà
La legge di Murphy, cara ENAC, non è scienza, ma un aneddoto: una “legge” scherzosa, un insieme di paradossi pseudo-scientifici a carattere ironico e caricaturale. Si possono idealmente riassumere nel primo assioma, che è in realtà la “Legge di Murphy” vera e propria, che ha dato il titolo a tutto il pensiero “murphologico” e hai pure citato sbagliato:
| «Se qualcosa può andar male, lo farà.» |
A parte che hai inventato una definizione tutta tua (ma una barzelletta se non la sai raccontare non fa ridere), che ci fa una barzelletta nell’esame di un Ente pubblico? Oltretutto è anche evidentemente paradossale, essendo appunto una barzelletta che deve far ridere e non trasmettere chissà quale principio scientificamente riconosciuto: a quale modello statistico fai rifermento quando in una domanda d’esame e non in chiacchiere alla macchinetta del caffè regali validità scientifica a un aneddoto che nella sua definizione corretta originale recita «Se qualcosa può andar male, lo farà»? Ma dico, cara ENAC, ti rendi conto, vero, che questa “legge” dice che in caso ci sia una qualunque probabilità di incidente, per quanto piccola e insignificante, questo si verificherà necessariamente? Ma stiamo scherzando? Ah sì scusami cara ENAC, certo che stiamo scherzando, parliamo di una “legge” che per ridere postula che l’evento considerato inizialmente improbabile, alla prova dei fatti si verifica spesso o addirittura sempre, ovverosia al primo tentativo o esperimento. In questo si riassume l’effetto ironico delle frasi. E’ molto triste dover spiegare il senso di una barzelletta, specie a chi non ha senso dell’umorismo, e non tutti quelli che affrontano il tuo test hanno voglia di ridere, magari il test lo stanno prendendo sul serio e si aspettano domande su affermazioni basate su solide basi scientifiche e non aneddottiche.
Non sarebbe stato meglio, se proprio ci tenevi a fare dello spirito (perdonami, a mio parere fuori luogo in un esame), almeno formulare la domanda come “La scherzosa legge di Murphy?” No, sai, perché se uno ti dà retta per davvero (dubito, in questo caso) e da te impara che se qualcosa può andare male certamente lo farà, come legge scientifica, e come tale verificata sperimentalmente, scateni il panico. Pertanto fai uno sforzo di scientificità e dillo, magari anche sul tuo syllabus, che queste “leggi” sono affermazioni caricaturali sulla realtà, che distorcono a fini umoristici tanto la reale frequenza o probabilità di un fatto (dichiarandolo più probabile di quanto non sia veramente), tanto le valutazioni preventive operabili sul fatto stesso (confondendo la sgradevolezza e l’indesiderabilità di un fatto con la sua probabilità, che viene presunta essere alta in modo del tutto ingiustificato). Che fai, la togli, la modifichi o ci vuoi fare sorridere ancora a lungo con le di per sé divertentissime leggi di Murphy? Ok, forse volevi stemperare con un aneddoto la tensione dell’esame. Ma non credo che questo renda più spensierato e allegro il candidato, tutto sommato.
Questa è nel migliore dei casi una domanda sleale: a parte che la prima opzione di risposta è semplicemente surreale, totalmente illogica, sgrammaticata e senza né capo né coda, visto che in una riga sola si saltella allegramente tra il concetto di lontano in senso assoluto e metri buttati lì a casaccio, ed è evidentemente un errore che dovrebbe essere corretto subito, nel regolamento ENAC non esiste il concetto di “persone isolate”. Esiste invece il concetto di “persone sotto il controllo del pilota di APR“. Che possono essere isolate, raggruppate o disposte come gli pare e piace. E quindi per logica esiste anche quello di persone che NON sotto il controllo del pilota, ma di nuovo che siano isolate o raggruppate, in fila indiana o stese al sole, da sole o in compagnia, da dove salta fuori? Vuol dire che se una coppia passeggia mano nella mano posso volargli sulla testa, non essendo né isolate né assembramento e non sappiamo se sono o meno sotto il mio controllo, visto che il quiz non me lo dice, ed è l’unica cosa importante ai fini di dare una risposta sensata alla tua domanda incompleta e imprecisa?
| ART 9 comma 1: Tali operazioni (le non critiche, appunto, ndr) devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo del pilota di APR. Le attività ricreative rientrano nelle operazioni “non critiche”. |
E da dove salta fuori la distanza dagli assembramenti citato nelle opzioni di risposta? Che diciamolo subito non c’entra nulla con il concetto di persone raggruppate o isolate, dal momento che è definito così:
| Assembramenti di persone: raduni in cui le persone non sono in grado di disperdersi a causa della densità dei presenti. |
Quindi è questione di densità e non di isolamento e nemmeno di numero. E gli assembramenti non possono essere sorvolati, questo è chiaro, ma il regolamento ENAC NON stabilisce esplicitamente alcuna distanza minima dagli assembramenti. Tutt’al più stabilisce una distanza di 150 metri dalle aree congestionate, definite come “aree o agglomerati usati come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive e in generale aree dove si possono avere assembramenti, anche temporanei, di persone”. Aree congestionate e assembramenti dunque non sono sinonimi. Questo significa che se l’assembramento c’è già, non “si potrebbe avere” ma è una certezza che ci sia, e io lo devo riprendere, devo stare a 150 metri? Può essere, certo. Anzi, è estremamente probabile che se l’assembramento c’è per questo semplice fatto l’area sia congestionata. Ma è una interpretazione. E una interpretazione se non è supportata da una circolare o altri documenti che la palesino, non deve entrare in una domanda d’esame. Non fosse altro perché la nostra civiltà giuridica non dà a chi ha scritto la legge il monopolio della sua interpretazione, sarebbe troppo bello per i regolatori fare la legge e poi interpretarla come fa loro comodo. Per la precisione, l’Articolo 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale dà questo potere di interpretazione solo al magistrato. Da un esame di un ente pubblico ci aspettiamo domande leali, la cui risposta sia esplicita nei regolamenti, e non si dovrebbe richiedere una interpretazione ai candidati, visto che l’interpretazione non spetta né a loro, né a chi ha redatto il regolamento né tantomeno a chi ha scritto il quiz.
La terza opzione di risposta è una assurdità (perché mai il multicottero dovrebbe desiderare di mantenere il Nord magnetico?). Ok, ci sta ed è corretto che una risposta sia assurda, fintanto che è quella da scartare. Ma le prime due sono sinonimi, anche se bisogna avere una cultura scientifica e umanistica un briciolo più alta rispetto a quella, migliorabile, di chi ha scritto il quiz. Eh già, il magnetismo polare, per quanto termine certamente desueto, esiste ed è sinonimo del magnetismo terrestre.
Ma a che gioco stai giocando, cara ENAC? Dove vuoi arrivare con queste domande cavillose? Può essere utile sapere che il magnetometro è una bussola, ma ti pare leale chiedere al candidato di seguirti su questi ragionamenti cavillosi? Davvero una domanda sconcertante, viene da chiedersi per quale motivo è stata inserita: per verificare una conoscenza cruciale per la sicurezza e la cultura aeronautica o far perdere tempo in ragionamenti inutili a chi sta affrontando la prova? No, non ci siamo proprio. Anche perché se tu fai la cavillosa lo faccio anch’io: guarda un pò, il “magnetismo polare” esiste eccome, è un termine usato dai geologi ottocenteschi, e non è mai stato né confutato né deprecato. Visto che evidentemente non li conosci, sennò non avresti sbagliato questo quiz, come capita spesso a chi vuol fare il cavilloso e sul cavillo scivola, per emendare questo buco nella tua cultura ti consiglio di leggere “Memorie sul magnetismo in moto recitate nelle adunanze dei giorni 9 giugno e luglio” del dotto Prof. Dot. Cavalier Gabriello Grimaldi della Regia Accademia Lucchese, segretario perpetuo della medesima nella classe delle Scienze e Direttore del Gabinetto di Sua Altezza Reale il Duca di Lucca, dove troverai una dotta dissertazione sul Magnetismo Polare, e “tosto lei vedrà che la verga ha acquistato una forte virtù magnetica per influenza del solo magnetismo polare della Terra“. La verga, ti prego di non pensar male, è l’ago della bussola, non è la verga che le scuole di quel tempo usavano per dar bacchettate agi scolari impreparati. Quella verga oggi non si usa più. Ma per rimediare potresti almeno leggere “Sul magnetismo polare di palazzi ed altri edifizi in Torino”, dotta Memoria del prof. commendatore Silvestro Gherardi, onorevole membro della Regia Accademia Albertina. Una domanda sbagliata con due risposte giuste… Come la mettiamo? Il punto dovrebbe perderlo chi ha sbagliato a fare il quiz, non il candidato. O no?
Sicuramente la risposta è NO, visto che il Maanuale non esiste. O magari, cara ENAC, intendevi il Manuale con una A sola? In quel caso la risposta sarebbe sì, ma non è quello che mi hai chiesto. Fami sapere, resto in trepidante attesa. A proposito, ti piace ancora cavillare? No, così, giusto per sapere… Perché se ti piace ancora cavillare ti prego di spiegarmi quest’altra domanda:
A parte la fastidiosa cavillosità (Un FIR è una regione in cui è suddiviso lo spazio aereo, nella definizione di ICAO, ma questo significa automaticamente che è a sua volta uno spazio aereo? Lasciamo perdere per adesso, tanto so che mi dirai di sì, ma potevi scegliere qualcosa di più chiaro, tipo la UIR, almeno era evidente che non è interessata alle nostre operazioni, avresti ottenuto meno confusione e più concretezza). Ma ciò detto, che cosa volevi intendere con Drone con la D maiuscola? Un SAPR? Un aeromodello? Un Predator militare? Un aeromobile giocattolo, che non ti riguarda nemmeno? La questione, tu mi insegni, non è affatto banale: se è un SAPR allora entra in CTR e ATZ, oltre ovviamente alle FIR, visto che vola nell’aria a 120 metri di quota e quello spazio aereo è certamente dentro una delle nostre tre FIR.
Se invece è un quadricottero senza possibilità di volo automatico è sì un drone (sostantivo maschile, D minuscola, mica scriviamo in tedesco) ma non è un SAPR, è un aeromodello per tua stessa definizione: e come tale non entra nemmeno nei CTR, figuriamoci negli ATZ. Se è un Predator militare è chiaramente un drone, ma seguirà le regole sue. E magari entrerà pure nelle ATM.
E se è un aeromobile giocattolo è certamente un drone, ma cosa fa o non fa non sono affari tuoi. Mi deludi, ti sapevo cavillosa, ma anche precisa. Questa domanda posta così non ha senso: Drone, anzi, drone è un termine colloquiale generico. Per poter rispondere alla tua domanda occorre che mi dici cosa aveva in mente chi ha scritto il quiz. Posso tirare a indovinare, certo. Anzi scommetto una birra (che non posso bere prima di pilotare, ma sappiamo entrambi che si può bere prima di scrivere, anche se non sempre è consigliabile) che l’estensore intendesse “Un SAPR sotto i 25 kg in VLOS“. Ma è mai possibile che per sostenere l’esame di un Ente pubblico il candidato debba tirare a indovinare quel che aveva in testa il redattore del quiz? Il termine SAPR l’hai inventato tu. E dunque usalo, no? Almeno quando è indispensabile per distinguere tra categorie diverse di oggetti volanti, alcuni dei quali non sono nemmeno aeromobili e altri non ti riguardano neppure.
Questo che cos’è, cara ENAC? Un consiglio? Un riferimento a una norma, e in questo caso quale? Una best practice? Lasciando stare il Lost & Found, che riguarda più che altro le valigie perse negli aeroporti, impostare la posizione di Home e soprattutto usarla in caso di lost link a volte è consigliabile, altre volte no: dipende da cosa c’è in mezzo e dalle strategie che il drone segue per tornare a casa. Chiaro che se torna in linea retta e il pilota ha fatto un lungo giro per evitare un assembramento, il return to home è decisamente sconsigliabile, e l’RTH sarebbe meglio non usarlo affatto, visto che in caso di perdita del segnale il drone lo attiverà per davvero. Mentre altri APR tornano indietro come Pollicino rifacendo a ritroso il percorso dell’andata, e in questo caso a volte, non sempre, usare l’RTH è una buona cosa, naturalmente dopo averlo registrato correttamente e non necessariamente da dove abbiamo decollato. Alcuni hanno sensori anticollisione, e tornano a un certo livello di safety, altri no, e in questo la safety dell’RTH va analizzata con più attenzione. Non c’è un dogma RTH sì o no. Chi lo sa cosa incontrano i SAPR in volo automatico? E in ogni caso dove sta scritto che il pilota deve fare qualcosa, o in alternativa, dove sta scritto che non è necessario che faccia nulla? Dipenderà dal manuale del SAPR, o al limite da quello dell’Operatore. Che darà le indicazioni del caso, ponderate e verificate sulla natura delle operazioni e del SAPR stesso. Un quiz molto poco chiaro. A che serve, esattamente, questa domanda? E qual è la risposta che aveva in mente chi l’ha scritta?
Ok, so che potresti obiettare: “Bravo te, ma se l’HP non è settato e si perde il segnale, dove andrà a finire il drone?” Verissimo, cara ENAC. E’ un problema. Io non lo so cosa fa il drone, e nemmeno tu puoi saperlo: resterà lì fermo in stato comandi, dandoci il tempo di avvicinarci e tentare di recuperare il link? Atterrerà sul posto? Cercherà di tornare all’ultimo HP settato? Dipende da chi l’ha programmato. Io non posso saperlo, tu nemmeno ma il produttore certamente sì, e l’avrà messo nel Manuale do Volo, con tutte le spiegazioni e precauzioni del caso. Quindi fai benissimo a chiedere ai candidati di preoccuparsi dell’HP, è importante, ma perché tra le risposte previste non hai messo “Si assicurerà che L’RTH e relativo Home Point siano gestiti secondo quanto prescritto dai manuali di Volo?”
Il guaio è che secondo me non hai le idee molto chiare su cosa sia l’RTH e come funziona. Come faccio a saperlo? Da questa altra domanda sullo stesso argomento:
Tutte e tre le risposte sono sbagliate:
La prima è sbagliata perché è giusto che l’APR conosca la posizione attuale e la “quota” (in realtà l’altezza AGL, sorvoliamo per ora), dal momento che si dovrà portare alla altezza AGL di sicurezza, e se non sa a che altezza è non lo può certo fare. Ma anche se lo sapesse, se poi non sa dove andare gli servirà a poco.
La seconda è sbagliata in quanto è giusto che il drone conosca la “quota” (sic), di nuovo per potersi portare alla altezza AGL di sicurezza, ma della posizione di decollo non se ne fa nulla, visto che non è assolutamente detto che coincida con l’home point: pensiamo al caso non certo infrequente in cui il drone parte da una barca, in caso di RTH sarà meglio fissare un Home Point a terra, non certo sul ponte della barca stessa, per evitare che più che un’atterraggio il volo finisca in un ammaraggio con successiva esplorazione degli abissi marini. O che per qualsiasi ragione sia preferibile settare un home point diverso dal punto di decollo, per mille ragioni, magari perché siamo in montagna e ci sono rocce, meglio che l’HP sia in un bel prato libero che non sullo spuntone dal quale abbiamo deciso di decollare. Di novo manca il dato fondamentale, cioè dov’è l’Home Point (che, come abbiamo visto, può essere il punto di decollo ma può benissimo non esserlo). E manca pure un’altro “dettaglio”, cioè la posizione dell’APR: che se non sa dov’è non può andare da nessuna parte. Insomma, qui su tre cose che ci servono ne abbiamo solo una, la “quota”. Ma il povero APR non sa né dov’è né dove deve andare.
La terza è sbagliata perché come abbiamo visto il punto di decollo e l’Home Point sono due cose diverse, quindi il drone non sa dove andare. E oltretutto non sa nemmeno qual è la “quota”, quindi il poveretto come fa a sapere come portarsi alla altezza AGL di sicurezza se non sa a che altezza sta volando? .
Insomma, una domanda giusta con tre risposte sbagliate. Certo, potresti arrampicarti sui vetri per dire che c’è quel tal dronetto cinese che l’RTH lo fa come i kamikaze giapponesi, alla quota in cui si trova, o la va o la spacca. Se lo cerchi lo troverai di sicuro, produttori incoscienti ce ne sono a iosa. Ma tu sei una signora e sui vetri non ti arrampichi, quindi sai che questa non è assolutamente la normalità del mercato, dove chi progetta droni ha perfettamente chiaro cosa va fatto e cosa no in ottica di quella safety che tanto ti piace e non si sognerebbero mai di far scorrazzare un drone fuori controllo ad altezza inguine. Quindi che fai, cara ENAC, togli questo quiz o lo aggiusti? La risposta giusta te la dico io: “deve conoscere l’altezza AGL, la posizione dell’Home Point e la posizione attuale”. Servono tutte e tre, non può mancarne nemmeno una. Semplice geometria solida da scuola media. Solida, appunto: tre dimensioni, altezza compresa. Quindi non è uno scusabile errore di cavillaggio tra Home Point e posizione di decollo, ma dipende dal fatto che chi ha scritto il quiz non sapeva che le informazioni indispensabili e acquisite dai droni che si rispettino sono tre, non due. Anche a voler ammettere che home point e punto di decollo siano la stessa cosa, e non lo sono (ma potrebbero esserlo in certi casi), non esiste nessuna risposta corretta tra quelle proposte.
Uh, a proposito, cara ENAC, non parliamo di quota ma di altezza AGL. Una differenza che conosci benissimo. E allora perché tutte queste imprecisioni?
Assicurazioni
Per la prima e l’ultima opzione la risposta ovviamente è NO, ENAC si occupa di aerei e non di assicurazioni, può eventualmente (e l’ha fatto in passato) stabilire requisiti minimi, come il massimale, cioè fino a che ammontare minimo deve arrivare la copertura assicurativa (nei vecchi regolamenti era almeno circa 800 mila euro, ora questo requisito è scomparso), ma non può certo entrare nella trattativa commerciale tra il pilota e il suo assicuratore. Il Pilota non può certo scegliere autonomamente lui, sennò io deciderei di pagare 50 cent e siamo tutti contenti, salvo magari l’assicuratore che non si ripaga neanche il francobollo per mandarmi a quel paese.
Quindi la risposta sarà forse “dipende dal tipo di operazioni che si dichiara di voler fare“? E chi l’ha detto? Anzi, nella realtà del mercato assicurativo non è affatto così: Questa opzione di risposta non è puntuale in relazione alla reale situazione del mercato. Sono rare le polizze che dividono il premio per Tipo di operazioni (Non specializzata/ Specializzata critica /Specializzata non critica e magari domani anche EVLOS/BVLOS). La maggior parte delle polizze comprendono nello stesso premio tutte le tipologie di operazioni specializzate e anche le non specializzate. Nella realtà quotidiana, il premio attualmente è per la maggior parte delle compagnie calcolato in base al peso del drone, e quindi al danno potenziale che può arrecare a terzi. Quindi la risposta più (relativamente) corretta sarebbe “Viene usualmente calcolata in base al peso del SAPR”. Peccato che nel quiz la risposta giusta non ci sia, dobbiamo scegliere tra ben tre risposte sbagliate, o nella migliore delle ipotesi due opzioni fantasiose e una molto imprecisa. Era proprio necessario fare una domanda del genere? Tra l’altro sono affari che riguardano esclusivamente il rapporto tra l’assicurato e il suo assicuratore, che c’entra la regolamentazione aeronautica? Cosa aggiunge questa domanda alla sicurezza del volo e quella di chi sta a terra? E se proprio era necessario, perché non mettere almeno una opzione di risposta coerente con la realtà?
L’assicurazione del solo mezzo APR:
° copre i danni a terzi che il drone può causare
° copre solo i danni causati ad altri oggetti o cose
° copre i danni materiali e diretti che il drone può subire
Il premio da pagare per l’assicurazione del solo mezzo APR
° dipende dal valore commerciale dell’APR più costoso in commercio
° lo decide l’ENAC
° è proporzionale al valore commerciale del mezzo
Cara ENAC, che cosa è mai “l’assicurazione del solo mezzo APR“? Una RC su un solo SAPR? Una Kasko? Una polizza per danni propri? Una polizza “Corpi?”
Le parole sono importanti, specialmente in un esame. Vedendole insieme, queste domande imprecise mi fanno scommettere la solita birra ormai sgasata che tu ti riferisca o a “Corpi”, o “Kasko” o “Danni Propri” e non a una RC per un singolo APR. A seconda sei casi, le risposte sono diverse: una “Danni Propri” copre anche danni al pilota, alla sua azienda, ai suoi dipendenti e familiari, oltre alle cose di loro proprietà, e non è affatto detto che sia proporzionale al costo dell’APR. Anzi, di solito non lo è. Una “Corpi” spesso copre anche altri rischi, come furto parziale (per esempio se ci fregano la radio ma non il drone) e le spese di rimozione del relitto (che può essere importante, se un drone finisce in un posto dove l’accesso è difficile ma va comunque messo in sicurezza visto che le LiPO potrebbero andare in corto e scatenare un incendio). E di nuovo il premio dipende più dalle garanzie offerte che non dal valore del mezzo. Invece una Kasko di solito copre solo i danni al mezzo, e in questo caso sì, di solito c’è questa proporzionalità premio/valore assicurato, che a sua volta però è ben diverso dal valore commerciale, dove l’hai pescata questa buffa definizione? Che facciamo, se abbiamo un sinistro e distruggiamo il drone andiamo a vedere a quanto lo mette BangGood?
Percezione
L’occhio…
° percepisce più dell’orecchio
° percepisce meno dell’orecchio
° percepisce allo stesso modo dell’orecchio
Che cosa intendevi esattamente con “percezione”, cara ENAC? In quale contesto? Di notte? Di giorno? in un campo di mais? Allo stadio? E percepisce “cosa”? Dove hai studiato neuroscienze? Te lo chiedo non per mettere in dubbio le tue sicuramente altissime competenze in fisiologia umana, ma giusto per capire cosa intendevi per “percezione”: percezione di un pericolo? Percezione di un movimento? Percezione del paesaggio? Percezione della conversazione con un helper, un osservatore o un collaboratore? Se non me lo dici la tua domanda non ha nessun senso.
Intendevi forse riferirti, un poco goffamente, all’ Effetto McGurk? In questo caso l’interazione occhio/orecchio è molto sottile e difficile dare un peso specifico a entrambe, e comunque vince l’orecchio, ma forse non ti riferivi a questo sennò l’avresti detto, suppongo. Volevi invece riferirti al lavoro di Wareham e Wright, più recente, parliamo del 2005? Beh, anche qui siamo sulle sabbie mobili, ma almeno hanno dimostrato come l’inconsistenza dell’informazione visiva può cambiare la percezione delle frasi ascoltate, spostando la bilancia verso l’occhio e meno dall’orecchio. Uhm. Però questa ricerca non dà percentuali, che facciamo? Tiriamo a indovinare? Ti riferivi forse al lavoro di Bradley Greger dell’Università dello Utah, che ha dimostrato che i segnali neurali che nel cervello dovrebbero essere guidati dal suono sono bypassati da quelli visivi? O magari hai studiato neuroscienze presso la Wake Forest University, al Baptist Medical Center o all’Università della Carolina del Nord? Spero di no, perché le loro ricerche hanno dimostrato che la prevalenza dell’uno e dell’altro senso è soggettiva e dipende appunto dal contesto. Quindi secondo queste fonti scientifiche di prestigio internazionale tra le tue proposte di risposta semplicemente nessuna è giusta. Quindi, tralasciando il fatto che occhio e orecchio fanno cose diverse ma sono interconnessi, mi dici dove hai studiato neuroscienze così posso risponderti sulla base scientifica, secondo gli insegnamenti della Tua scuola?
Se non me lo dici, dimmi almeno se hai fatto il Classico, e quanto avevi di di greco in pagella: così alla peggio posso pescare da Eraclito di Efeso: “Gli occhi sono testimoni più precisi delle orecchie”. Ma magari tu pensavi a Erodoto di Alicarnasso: “Gli uomini si fidano delle orecchie meno che degli occhi”. Ipse dixit. E tu che dixit?
Dove hai pescato questa tua granitica certezza che un organo percepisca più di un’altro in ogni scenario e ogni occasione, da parte di qualsiasi persona in qualunque contesto? Mi sa che conta solo chi te l’ha detto, o magari te l’ha fatto vedere. Quindi al lavoro scientifico di chi ti riferisci? E pubblicato quando e su quale rivista scientifica internazionale? E con quali condizioni al contorno nel suo esperimento? Mah, forse la sintesi di tutto questo l’ha fatta Milton Berle: La natura è fantastica. Un miliardo d’anni fa non avrebbe mai sospettato che noi avremmo portato gli occhiali, eppure ci ha fatto le orecchie!
In apertura: due ragazze si divertono a leggere gli aneddoti della Legge di Murphy